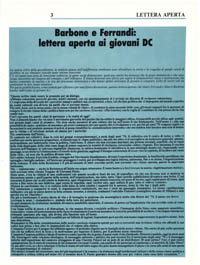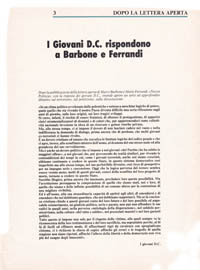Per non dimenticare
Questo scritto vuole essere la proposta per un dialogo. Abbiamo conosciuto parecchi giovani, nostri coetanei, con cui spontaneamente si è avviato un discorso di reciproca conoscenza.
Ci stupivamo della diversità dei «percorsi» umani e politici; noi ex-terroristi, e loro, voi che fate politica che vi impegnate nel mondo a partire da realtà culturali così diverse da quelle che ci avevano mosso.
Ma tutti, forse, con le stesse ansie, con la stessa volontà di «fare», di cambiare lo stato presente delle cose, gli stessi rapporti fra le persone; di rompere il circolo vizioso della «politica fatta solo per far carriera» (Guccini: «Dio è morto»), con la voglia di «cambiare la vita prima che la vita cambi noi».
Cos'è successo fra questi «dati di partenza» e la realtà di oggi?
Non ci dimentichiamo che voi siete il movimento giovanile del partito che ha subito le maggiori offese,irreparabili perché offese agli uomini, nel periodo degli «anni di piombo». Ma siete anche portatori di una cultura che ha nell'uomo il suo fondamento. Nell'uomo e nella sua possibilità di capire, cambiare ed emendare gli errori commessi; ed è per questo che ci rivolgiamo a voi, perché gli anni '70 vengono capiti e le lacerazioni in essi prodotte possano ricucirsi, si possa ristabilire la «comunicazione interrotta» che ora sembra solo lasciare una scia di dolore per le vittime e di reiezione sociale ed umana per i partecipi.
Ma cominciamo dall'inizio...
Si comincia nei collettivi, dopo la crisi dei gruppi extraparlamentari, a metà degli anni '70. Il collettivo era il centro di tutto; a volte vi confluivano anche presenze gruppettare, si discutevano le «linee politiche», ma più che altro vi si raccoglieva un malessere generale, umano, metropolitano, per indirizzarlo verso la politica, l'attivismo. È chiaro che non eravamo marziani, ma persone normali, sensibili che al vuoto della città disgregata, della città come luogo di potere espresso in termini di ricchezza, cercavamo «altre» risposte. Era insomma il vecchio discorso dell'impegno: si vedano ingiustizie clamorose, la cultura dominante le introduceva in una mitologia dentro cui rispettando certi passaggi, se ne otteneva l'eliminazione e il trionfo della giustizia; aggiungi il bisogno esistenziale di avere voce in capitolo, di incidere nel vuoto della citta... ed ecco che la politica diventa tutto.
Ed è subito violenza: il servizio d'ordine, retaggio del Movimento Studentesco, diventa l'esperienza dominante, la familiarità quotidiana con spranghe e bottiglie molotov. All'inizio per proteggere i cortei, poi si sviluppa una logica interna, autonoma, fine a se stessa l'organizzazione della violenza. Il mito della Resistenza è il più devastante di tutti; eravamo pochi, non eravamo «la» classe operaia, questo lo sapevamo benissimo.
Ma – ragionavamo – anche la Resistenza all'inizio era esigua minoranza. E tutto bastava a farci trovare la nostra «legittimazione storica», tutti avevamo letto «Senza Tregua» di Giovanni Pesce.
Sotto sotto, c'era la volontà di non confrontarsi con quanto accadeva fuori da noi, di sopraffare ciò che era diverso; non si metteva in discussione questo o quell'aspetto della società, dell'organizzazione, ma tutto, tutto. Ogni cartello pubblicitario diventava una ferita. Ogni marasma di gente che va allo stadio la domenica, ogni telegiornale, ogni minuto trascorso sul posto di lavoro, ogni registratore di cassa, ogni uscita a fine turno da una fabbrica, ogni corsia di ospedale, ogni vecchio solo, ogni zaffata di gas, tutto si vedeva «contro». Matura la convinzione che ci si realizza nella lotta: la lotta cambia i rapporti fra le persone, muta la vita tua e degli altri.
Poi cominciano a comparire le armi, le organizzazioni combattenti, ma non è stato un passaggio traumatico.
Lo stesso «antifascismo militare» era già un passo dentro la lotta armata: nessuno, a sinistra, condannò l'omicidio Pedenovi (consigliere missino di Milano) e solo perché era un «fascista»!
Da qui a trasformare il nostro ideale di vita e di battaglia in qualcosa che assomigliava molto alla Beirut del '75, il passo era breve.
Arrivano le armi, i «kalashnikov», simbolo della lotta dei palestinesi.
In quel momento la rivoluzione mondiale diventava possibilità materiale, il sistema di potere un'impalcatura che non avrebbe retto al vento rivoluzionario...
Una lunga trafila di morte e di distruzione, la vita diventa «variabile politica»: l'immagine dello Stato come apparato monolitico, tentacolare, votato all'annientamento delle forze rivoluzionarie ti porta ad assumere la concreta possibilità di uccidere.
Uno slogan risuona nei tribunali: spariamo alla toga, alla divisa; alla funzione non all'uomo.
I militari combattenti sono finiti sconfitti per un'infinità di ragioni.
Soprattutto però perché non hanno rappresentato in positivo niente.
Solo una distruzione.
Riannodare le fila della contaminazione delle nostre coscienze comporta quindi per noi ex-terroristi una revisione critica che affondi le sue radici ben prima e ben oltre le imputazioni che ci vedono alla sbarra.
Comporta l'orrore per il sangue che abbiamo sparso e il profondo rispetto per le famiglie delle nostre vittime.
Ma anche di più, oggi in pieni anni '80, interrogarci sulla relazione ideologica, di messaggio culturale e politico che può trovarsi tra il terrorismo degli anni '70 e il messaggio inferito dall'esposizione del cadavere oltraggiato di una Claretta Petacci ad un palo di un distributore 30 anni prima?
Non ci può essere equiparazione fra lo stato di coscienza di chi assassinò Giovanni Gentile, con quello di chi partecipò al rapimento e al martirio di Aldo Moro?
O, per altri versi, se e dove relazione vi fu fra le trame di tutt'altro segno che pure hanno insanguinato il paese e corsa alle armi di una quota di extraparlamentari di sinistra?
Dei misteri irrisolti del terrorismo, uno dei più inquietanti è la remota e la titubanza degli intellettuali e della stessa classe politica a sottoporlo a critica, critica nel senso che al termine dava S. Paolo: guardare dentro alle cose per vedere come sono fatte veramente?
La risposta su Nuova Politica
Il un clima politico avvelenato dalle polemiche e sotteso a meschine logiche di potere, quale quello che sta vivendo il nostro Paese, diventa difficile una seria riflessione sugli anni di piombo sulle loro origini, sui loro tragici sviluppi.
Si corre, infatti, il rischio di essere fraintesi, di sfiorare il protagonismo, si apparire cinici strumentalizzatori di drammi e di dolori che, pur appartenendoci come collettività nazionale investono la sfera di un ricercato e geloso riserbo privato.
Ma, allo stesso tempo, ci si impone il dovere di non lasciar cadere nel vuoto e nella indifferenza la domanda di dialogo, prima ancora che di perdono, che molti giovani ex-terroristi ci hanno rivolto.
È un dovere cristiano ed umano che travalica le limitate logiche del codice penale e che ci apre, invece, allo sconfinato mistero dell'uomo, al dramma del suo male ed alla grandezza del suo ravvedimento.
Ma è ache un dovere politico che si impone a noi giovani «del Partito che ha subito le maggiori offese», a noi giovani che, pur provenendo da realtà similari, pur vivendo le contraddizioni dei tempi in cui, come i giovani terroristi, anche noi siamo cresciuti, abbiamo continuato a credere in questo Stato, in questo sistema democratico così imperfetto ma allo stesso tempo, nel suo perfettibile divenire, così ricco di prospettive per un impegno serio e coscienzioso. Oggi che a logica perversa del terrore sembra essere venuta meno, molti di questi giovani, consci della sconfitta del loro progetto di morte, tornano a credere in questo Stato.
Sarebbe illogico, prima ancora che insensato, precludere loro questa possibilità. Ma l'accettazione presuppone la comprensione di quello che siamo stati, noi e loro, di quello che siamo e delle infinite possibilità di un comune sforzo per la costruzione di una migliore vivibilità.
Ed è all'uomo, alla sua straordinaria capacità di aprirsi agli altri, di emendarsi e di emendare che noi dobbiamo guardare, che noi dobbiamo rapportarci. Ma se la coscienza cristiana chiede a questi giovani conto del loro futuro e del loro possibile ed augurabile reinserimento, un giudizio politico, serio e pacato, non può non affondare le sue radici in quegli anni, nella perversa «mitologia della disperazione», nel subdolo permissivismo, nella cultura «del tutto e subito», nei prezzolati maestri e nei loro garantiti politici.
Tutto questo si impone non solo per il rispetto delle vittime, alle quali sempre va la riconoscenza della loro testimonianza e del loro sacrificio, ma soprattutto perché, al di là di facili ed effimere mode, di affascinanti tigri da cavalcare con spregiudicato cinismo, ci è richiesto lo sforzo di capire affinché gli errori e le tragedie di quella stagione non siano ripetuti, affinché l'albero della libertà e della democrazia non viva più del sangue degli innocenti».
I giovani dc