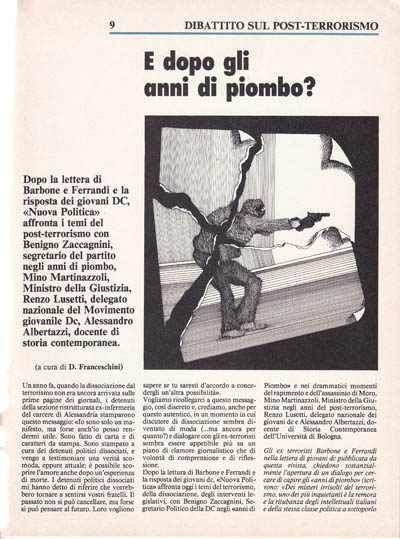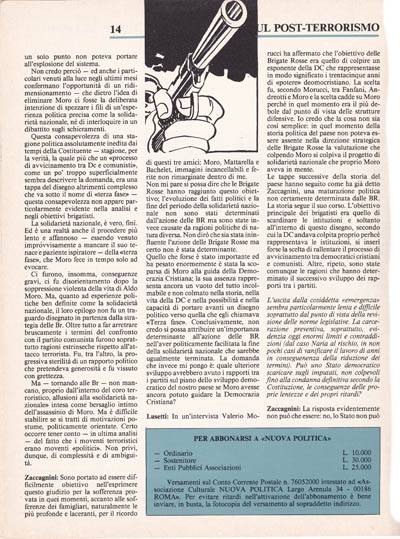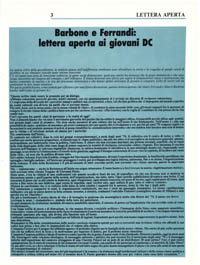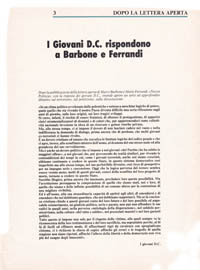E dopo gli anni di piombo?
Un anno fa, quando la dissociazione dal terrorismo non era ancora arrivata sulle prime pagine dei giornali, i detenuti della sezione ristrutturata ex-infermeria del carcere di Alessandria stamparono questo messaggio: «Io sono solo un manifesto, ma forse anch'io posso rendermi utile. Sono fatto di carta e di caratteri da stampa. Sono stampato a cura dei detenuti politici dissociati, e vengo a testimoniare una verità scomoda, eppure attuale: è possibile scoprire l'amore anche dopo un'esperienza di morte. I detenuti politici dissociati mi hanno detto di riferire che vorrebbero tornare a sentirsi vostri fratelli. Il passato non si può cancellare, ma forse si può pensare al futuro. Loro vogliono sapere se tu saresti d'accordo a concedergli un'altra possibilità».
Vogliamo ricollegarci a questo messaggio, così discreto e, crediamo, anche per questo autentico, in un momento in cui discutere di dissociazione sembra diventato di moda (...ma ancora per quanto?) e dialogare con gli ex-terroristi sembra essere appetibile più su un piano di clamore giornalistico che di volontà di comprensione e di riflessione.
Dopo la lettura di Barbone e Ferrandi e la risposta dei giovani dc, «Nuova Politica» affronta oggi i temi del terrorismo, della dissociazione, degli interventi legislativi, con Benigno Zaccagnini, Segretario Politico della DC negli «anni di Piombo» e nei drammatici momenti del rapimento e dell'assassinio di Moro, Mino Martinazzoli, ministro della Giustizia negli anni del post-terrorismo, Renzo Lusetti, delegato nazionale dei giovani dc e Alessandro Albertazzi, docente di Storia Contemporanea dell'Università di Bologna.
Gli ex terroristi Barbone e Ferrandi nella lettera di giovani dc pubblicata da questa rivista, chiedono sostanzialmente l'apertura di un dialogo per cercare di capire gli «anni di piombo» (scrivono: «Dei misteri irrisolti del terrorismo, uno dei più inquietanti è la remora e la titubanza degli intellettuali italiani e della stessa classe politica a sottoporlo a critica nel senso che al termine dava S. Paolo: guardare dentro alle cose per vedere come sono fatte veramente».) ma anche perché le «lacerazioni» prodotte negli anni 70 possano «ricucirsi».
È possibile oggi cercare di seguire questa strada?
Lusetti: Due sono le richieste che ci vengono da Barbone e Ferrandi: dialogare, per cercare di comprendere gli anni di «lucida follia» del terrore, come li hanno chiamati, cercando però anche una sorta di «ricucitura» o di rapporto di ricostruzioni comune di quanto si è lacerato negli anni 70. Noi dobbiamo operare secondo una sorta di «strategia dell'attenzione» rispetto a quanto sta maturando ed emergendo nel dibattito tra i protagonisti degli anni di piombo. La proposta di dialogo va accettata, per cercare di capire come mai giovani della nostra stessa generazione (è la domanda che anche gli ex terroristi oggi si pongono) seguirono una strada così diversa da quella del nostro impegno politico. rei confronto noi giovani dc che, come abbiamo scritto nel numero precedente di «Nuova Politica», «abbiamo continuato a credere in questo stato così imperfetto ma così ricco di prospettive per un impegno serio e coscienzioso», dobbiamo riuscire a dimostrare con la nostra esperienza, con il nostro stile, con la serietà del nostro lavoro, che era possibile e giusto, allora come oggi, impegnarsi dentro le istituzioni per costruire e cambiare e non per distruggerle, seminando soltanto morte e disperazione.
Zaccagnini: Una delle cose più importanti che emergono è questa volontà di dialogo proposta alle forze politiche e spirituali da parte di coloro che hanno vissuto l'esperienza del terrorismo, credo sia proprio questo bisogno di ripensare criticamente atteggiamenti, frutto di una logica impazzita, per ritrovare un discorso comune con altri uomini, portatori di diversi valori politici e morali, per tentare di «veder dentro» alle cose. È un modo per uscire da giudizi precostituiti che schematizzano ciò che in realtà, non è mai schematizzabile, com'è il dramma di una coscienza umana. Da qui nasce una considerazione: non si può demonizzare nessuno ma bisogna sempre avere quel filo di speranza cristiana che apre la prospettiva di un ripensamento critico da parte anche di quelli che, negli «anni di piombo», ci sembravano forse irrecuperabili.
Il fenomeno della dissociazione mi pare abbia proprio quest'importante risvolto: rendere evidente che il cuore dell'uomo è sempre possibile di aperture e di dialogo ai quali certamente non si può rispondere negativamente ma bisogna rispondere con altrettanta disponibilità. Non si possono certo dimenticare le conseguenze che il terrorismo ha causato in termini di dolore, di sofferenza e di sangue ma si può cercare di guardare avanti ad una possibilità di dialogo e di comprensione. Si può arrivare a capire, perlomeno a capire, quali motivazioni vi erano, se vi erano, quali errori sono stati compiuti, quali errori potevano esserci nella struttura della nostra società per rendere possibile questa forma impazzita di reazione violenta.
Credo non sia un caso che proprio dalla preghiera di Giovanni Bachelet al funerale di suo padre, sia iniziato questo processo di revisione e di «chiamata in causa» della coscienza al di là del fanatismo ideologico che caratterizzava l'azione di questi giovani. È profondamente utile per loro e per noi cercare di vedere dentro alle cose. In fondo gli uomini hanno soprattuto questo bisogno: cercare di capire le ragioni degli altri per trovare al fondo quello che io credo esista sempre: un terreno comune di valori, che possono essere anche distorti e visti in certi momenti in modo aberrante, ma che non possono prima o poi non affiorare come valori comuni della coscienza umana.
Martinazzoli: È possibile, ma senza illudersi che esistano risposte facili a problemi complessi. E quello della uscita degli «anni di piombo» della «comprensione» di una stagione così aspra, resta un problema complesso.
Gli stessi gesti moltiplicatisi in questi mesi, gesti anche semplici nel segno della «riconciliazione», sono schegge di speranza che confermano la verità di un tragitto, ma non lo rendono per questo meno duro e impegnativo. Per tutti. Per le istituzioni, la società civile, gli intellettuali, i giovani stessi che hanno abbandonato l'ideologia della violenza.
Certo, «ricucire le lacerazioni» è l'impegno, ma le ferite sono ancora aperte e al tavolo del dialogo occorre avvicinarsi con il pudore che questa prossimità comporta. Lo esige un senso di rispetto verso il dolore di troppe famiglie insensatamente distrutte.
Lo scavo nella coscienza, l'interrogarsi di giovani sino a qualche anno fa accecati dal mito della lotta armata merita il massimo di considerazione ma è un lavoro innanzitutto interiore che dovrebbe circondarsi, forse di maggior riserbo, e non consumarsi in una esclamazione o diventare merce da scoop giornalistico. Così banalizzato rischia di essere uno sforzo non capito o addirittura sospetto.
Il tentativo di accreditarsi protagonisti e interlocutori, pubblicamente e subito oggi, quasi cercando una patente di autorevolezza anche nel dibattito sociale e politico, è un atteggiamento che stride, se è vero che la memoria di azioni dissennate è ancora così viva nel tessuto del Paese. Dialogo sì, ma una misura maggiore, forse, non guasterebbe.
Tendo a credere, del resto, che la questione è assai più complessa di come talvolta viene descritta. Il fatto è che un lungo itinerario di violenza e di terrore ha rappresentato l'attacco più penetrante e insidioso allo Stato democratico che mai si sia registrato dalla fondazione della Repubblica. Ciò che manca, allora, non è tanto una biografia dei sentimenti ma proprio una storia del terrori mo. Che questa storia risulti tuttora inesplorata è il segno della difficoltà che, da ogni versante, c'è verso una analisi veritiera. Sembra che ciascuno intenda uscire dall'«emergenza» portandosi dietro le «ragioni» dell'emergenza. Ma questa sarebbe, esattamente, una mediocre rimozione.
Albertazzi: Occorre fare due considerazioni: innanzitutto va detto che durante gli «anni di piombo» non solo lo Stato ma tutta la società civile ha dovuto prima di tutto difendersi per difendere il regime democratico entro il quale credeva di poter continuare ancora a vivere e a progredire. La seconda considerazione è che occorre lasciar trascorrere del tempo per poter comprendere veramente; mancano molti documenti e del resto l'inquietudine e la titubanza, di cui Barbone e Ferrandi parlano, sono proprio dovute al fatto che non si riesce ancora a scoprire la prospettiva e il modo in cui «guardare dentro» alle cose. Credo che i vari tentativi finora fatti possano servire ad una storia futura. Già oggi però cominciamo a riflettere, in particolare il mondo cattolico comincia a riflettere, a ricucire pur non conoscendo moltissime cose ma conoscendo una cosa importante: l'intuizione di Paolo VI quando cominciò la sua lettera, in un periodo difficilissimo per la vita italiana e per lui, amico di Aldo Moro, chiamando gli appartenenti alle Brigate Rosse: uomini.
In un passaggio della lettera Barbone e Ferrandi sostengono che il mito della Resistenza ebbe un ruolo «devastante» nella scelta di violenza di tanti terroristi. Pongono anche un provocatorio interrogativo: «Desterà scandalo, oggi in pieni anni '80, interrogarci sulla relazione ideologica, di messaggio culturale e politico che può trovarsi fra il terrorismo degli anni '70 e il messaggio inferito dall'esposizione del cadavere oltraggiato di una Claretta Petacci ad un palo di un distributore 30 anni prima? Non ci può essere equiparazione fra lo stato di coscienza di chi assassinò Giovanni Gentile, con quello di chi partecipò al rapimento e al martirio di Aldo Moro?».
Zaccagnini: Questo è certamente il passaggio più provocatorio della lettera, almeno per chi come me, ha partecipato alla Resistenza. Mi ha colpito questo richiamo ai valori della Resistenza per giustificare una posizione di natura del tutto diversa; la lotta di Liberazione fu certo frutto di un movimento necessariamente armato, per le condizioni storiche in cui ci siamo trovati ad operare, ma quel che deve essere tenuto presente è che la Resistenza è stata una ribellione, come diceva la preghiera di Olivelli, una «ribellione per amore» che cercava di proporre valori in positivo; non era tanto una lotta «anti» ma era una lotta «per», per la pace, la libertà, l'uguaglianza, la dignità dell'uomo, una guerra alla guerra.
La lettera stessa degli ex terroristi che vi è stata inviata denuncia d'altronde nell'esame delle loro vecchie posizioni, che «I militanti combattenti sono finiti sconfitti per una infinità di ragioni. Soprattutto però perché non hanno rappresentato in positivo niente. Solo una distruzione». È questo l'aspetto forse più importante di questo loro riesame critico: il fatto di sentire che essi non erano l'avanguardia di un moto popolare, ma anzi si erano posti in una posizione di antitesi e di isolamento rispetto alla coscienza del popolo; la Resistenza invece fu proprio interprete di questa coscienza. Questo può essere motivo di riflessione utile per non confondere due cose che non sono assolutamente comparabili. Mi rendo conto che gli episodi più tragici, come quelli citati, della esperienza partigiana possono sembrare fatti giustificanti la violenza, ma in realtà i valori più profondi della Resistenza, anche se si fu costretti a ricorrere alla lotta armata, restarono la pace e la volontà di sconfiggere la violenza di quegli anni.
Albertazzi: Su questo punto credo, proprio per il mestiere che tento di fare, che le interpretazioni, anche queste agevolate da alcuni intellettuali negli anni 68/72, sulla Resistenza come «rivoluzione mancata», siano inesatte e soprattuno insussistenti. Intanto per cominciare va valutato bene che mentre nel periodo del terrorismo non vi era alcun stato di guerra là eravamo, come già ha detto Zaccagnini, nel pieno della tragedia di una guerra, con tutto ciò che questo comporta. In secondo luogo non eravamo in un regime democratico ma uscivamo da un regime dittatoriale in cui la libertà non era ammessa. Va detto poi che la Resistenza deve essere di nuovo rimeditata come storia della società, come storia sociale e non soltanto come storia politica, dell'azione dei partiti. dell'attività militare dei partigiani, classificati in buoni e cattivi. Non è possibile continuare su questa strada di rapporto storiografico dopo quarant'anni: occorre cominciare, come hanno fano le altre storiografie per gli altri grandi periodi della loro storia (la rivoluzione americana, la rivoluzione francese), a capire la storia della società e vederci dentro, tenendo conto dei risultati raggiunti ma andando avanti. Durante la Resistenza si è modificato un rapporto di solidarietà, si è riaperta una prospettiva, è iniziata una profonda trasformazione che non si riflette soltanto nella Costituzione ma anche, ancora. in molti uomini. Va capita e recuperata la realtà, non «il mito» della Resistenza.
Il fenomeno della «dissociazione» diversàmente del «pentitismo» è nato, come fatto spontaneo, come conseguenza di una riflessione autocritica di tanti exterroristi, emersa autonomamente e non in previsione di possibili benefici di legge. Non ritenete che l'ipotesi di un intenvento legislativo rischi di divenire un elemento inquinante nello stesso movimento dei dissociati?
Lusetti: Il fenomeno della dissociazione è certamente diverso dal pentitismo. Il dissociato è un ex-terrorista che ha portato a termine una riflessione critica basata sulla propria coscienza, un processo di maturazione rispetto all'esperienza passata; tutto ciò è avvenuto, fin dagli inizi di questo fenomeno, all'interno delle carceri, senza avere dinnazi l'ipotesi di interventi legislativi.
Ora esiste l'ipotesi di disciplinare la dissociazione. Mi pare si debba procedere con molta cautela; la legge sui pentiti aveva l'obiettivo, da parte dello Stato, di fare collaborare i terroristi attraverso una confessione utile per la sconfitta del terrorismo stesso; la dissociazione ha un significato politico e sociale diverso che richiede un intervento diverso e più complesso. Esiste innanzitutto il problema di individuare e ricondurre a categorie precise, perché ovviamente una legge non può avere margini di incertezza, una scelta di coscienza e di maturazione politica, personale o di gruppo, com'è quella che sta alla base della dissociazione.
Se l'intervento legislativo introdurrà solo benefici di pena rischlerà senz'altro di divenire un elemento inquinante rispetto alla «spontaneità» che ha caratterizzato il fenomeno; diversa è l'ipotesi di una legge che vada a disciplinare una situazione di fatto che esiste nelle carceri e che non può essere ignorata, perché costituisce un fatto rilevantissimo dal punto di vista umano e sociale, della società esterna.
Zaccagnini: Questo problema credo debba essere esaminato non solo tra le forze politiche ma anche tra quelle culturali, per riflettere e capire e quindi per arrivare anche ad eventuali provvedimenti legislativi. Però, come ritengo che il carcere non possa essere l'unica risposta possibile da dare ad un dramma di coscienza, non credo neanche che sia possibile attraverso strumenti giuridici dare voce a queste espressioni della dissociazione. Vi è qualcosa di più profondo che, specialmente per chi si richiama ad una ispirazione cristiana, va tenuto presente: una distinzione tra il concetto di giustizia sul piano dello Stato, rappresentato dalla bilancia che deve porre in equilibrio i danni sociali commessi e le pene, e su quello della dimensione cristiana, in cui la giustizia si ristabilisce in termini di riscoperta della verità, al di là del male compiuto: se ciò avviene, ciò che era stato lacerato, per la giustizia cristiana, si è già ricucito; la conversione del cuore comporta già il superamento del male compiuto per arrivare ad una pacificazione con la giustizia che, nel senso più alto della parola, è Dio stesso.
Tutto ciò mi pare non si traducibile in termini legislativi: occorre stare molto attenti nel pensare ad un intervento su questo tema. Io non lo vedo a priori come un fatto negativo ma credo vada ripensato attraverso uno sforzo culturale importante fatto insieme con gli stessi dissociati, ascoltandoli e dialogando con loro, ma anche avviando un dibattito tra le forze politiche, e soprattutto su un piano culturale, in grado di accompagnare la stesura di un provvedimento del genere.
Martinazzoli: I «dissociati», prendendo le distanze dalla lotta armata, hanno anche cercato un rapporto e un dialogo con lo Stato che sino a ieri avevano fanaticamente combattuto. Hanno detto di voler offrire gesti di pacificazione e hanno invocato altrettanto dalle istituzioni. Non mi pare che il fine ultimo del movimento cresciuto nelle carceri sia una sorta di sacralizzazione dello status di «dissociato» (il che – se fosse – dovrebbe preoccupare non poco).
È continuo infatti, nei documenti dell'area della dissociazione, il rinvio al superamento della cosiddetta legislazione di emergenza, anche in relazione a una possibile riconsiderazione delle sanzioni previste per i reati associativi.
È chiaro che instaurare un rapporto significa sempre, da entrambe le parti, esporsi a rischi. Il problema però non è di rinunciare alla scommessa – soprattutto se, come in questo caso, il valore in gioco la consiglia – ma di affrontarla su basi di chiarezza e coerenza reciproca. la fatica è qui, nel costruire uno strumento normativo che riconosca una evoluzione «in positivo» e che, nello stesso tempo, contempli un giudizio di valore preciso e inequivocabile su fatti e progetti che per anni hanno insanguinato il Paese.
Per questo non uno, ma diversi sono i criteri che debbono concorrere, insieme, alla prova della dissociazione. Non ultimo quello della ammissione dei reati commessi, dal momento che sarebbe ben strano che pretendesse di dirsi «dissociato» colui il quale rifiutasse di riconoscere di essersi anche solo «associato».
Si farà in modo di ridurre al minimo i sempre possibili rischi di «inquinamento», cioè di dissociazioni solo strumentali. L'esistenza di questo pericolo, d'altra parte, non pare sufficiente a sconsigliare la strada della predisposizione di una legge.
Durante e dopo il rapimento e l'assassinio di Moro si sostenne, in più occasioni, che l'obiettivo delle Brigate Rosse era quello di bloccare, colpendo proprio Moro in quel momento della vita politica del Paese, il processo di avvicinamento tra DC e comunisti ed il periodo della «solidarietà nazionale». Oggi le BR sono state sconfitte dallo Stato ma non hanno, in fondo, raggiunto quell'obiettivo?
Albertazzi: L'aspetto politico del problema ha un'immagine precisa: il corpo di Moro lasciato tra le due sedi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Se questo era l'obiettivo dei terroristi, non è stato raggiunto perché vi sono ancora uomini dall'una e dall'altra parte, non mi interessa tanto da un punto di vista preminentemente politico ma nei processi sociali, negli atteggiamenti, che cercano ancora oggi di comprendersi, di testimoniare la loro comprensione. Certo saltando le loro bandiere, i loro programmi, difendendoli anche accesamente, quando necessario, ma cercando di comprendere, perché questo è il significato della democrazia ed è il grande risultato che ha ottenuto in questo paese il partito dei cattolici democratici: fare in modo di trovare anche nell'avversario non il nemico ma uno che comunque ha qualcosa da dire e serve sempre per mantenere viva una società che ancora oggi sta in piedi in forza anche delle due più grandi forze popolari. Resta il fatto che in una realtà politica complessa come quella italiana (nessuna riforma delle istituzioni potrà modificarla perché è troppo importante averla come tale) il rapporto tra queste due forze sarà sempre meno semplicistico di un «avvicinamento» o di un «compromesso storico» o di un raggiungimento di obiettivi comuni soltanto a fini di guida del governo.
Martinazzoli: La ricostruzione della genesi del rapimento e dell'assassinio di Aldo Moro dà conto di un progetto assai semplicistico: colpire la personalità più rappresentativa della Dc per colpire il partito custode in assoluto del potere e dei suoi segreti.
Il calcolo era clamorosamente sbagliato, le Br non valutarono affatto la natura propria di un potere che le dinamiche sociali avevano reso progressivamente diffuso e parcellizzato, Colpire in un solo punto non poteva portare all'esplosione del sistema.
Non credo perciò – ed anche i particolari venuti alla luce negli ultimi mesi confermano l'opportunità di un ridimensionamento – che dietro l'idea di eliminare Moro ci fosse la deliberata intenzione di spezzare i fili di un'esperienza politica precisa come la solidarietà nazionale, né di interloquire in un dibattito sugli schieramenti.
Questa consapevolezza di una stagione politica assolutamente inedita dai tempi della Costituente – stagione, per la verità. la quale più che un «processo di avvicinamento tra Dc e comunisti», come un po' troppo superficialmente sembra descrivere la domanda, era una tappa del disegno altrimenti complesso che va sono il nome di «terza fase» – questa consapevolezza non appare particolarmente evidente nella analisi e negli obiettivi dei brigatisti.
La solidarietà nazionale, è vero, finì. Ed è una realtà anche il procedere più lento e affannoso – essendo venuto improvvisamente a mancare il suo tenace e paziente ispiratore – della «terza fase», che Moro fece in tempo solo ad evocare.
Ci furono, insomma, conseguenze gravi, ci fu disorientamento dopo la soppressione violenta della vita di Aldo Moro. Ma, quanto ad esperienze politiche ben definite come la solidarietà nazionale, il loro epilogo non fu un traguardo disegnato in partenza dalla strategia delle Br. Oltre tutto a far arretrare bruscamente i termini del confronto con il partito comunista furono soprattutto ragioni estrinseche rispetto all'attacco terrorista. Fu, tra l'altro, la progressiva sterilità di un rapporto politico che pretendeva generosità e fu vissuto con grettezza.
Ma – tornando alle Br – non mancano, proprio dall'interno del coro terroristico, allusioni alla «solidarietà nazionale» intesa come bersaglio intimo dell'assassinio di Moro. Ma è difficile stabilire se si tratti di motivazioni postume, politicamente orientate. Certo occorre tener conto – in ultima analisi – del fatto che i moventi terroristici erano moventi «politici». Non privi, dunque, di complessità e di ambiguità.
Zaccagnini: Sono portato ad essere difficilmente obiettivo nell'esprimere questo giudizio per la sofferenza provata in quei momenti, accanto alle sofferenze dei famigliari, naturalmente le più profonde e laceranti, per il ricordo di questi tre amici: Moro, Mattarella e Bachelet, immagini incancellabili e ferite non rimarginate dentro di me.
Non mi pare si possa dire che le Brigate Rosse hanno raggiunto questo obiettivo; l'evoluzione dei fatti politici e la fine del periodo della solidarietà nazionale non sono stati determinati dall'azione delle BR ma sono state invece causate da ragioni politiche di natura diversa. Non dirò che sia stata ininfluente l'azione delle Brigate Rosse ma certo non è stata determinante.
Quello che forse è stato importante ed ha pesato enormemente è stata la scoparsa di Moro alla guida della Democrazia Cristiana; la sua assenza rappresenta ancora un vuoto del tutto incolmabile e non colmato nella storia, nella vita della DC e nella possibilità e nella capacità di portare avanti un disegno politico verso quella che egli chiamava «Terza fase». Conclusivamente, non credo si possa attribuire un'importanza determinante all'azione delle BR nell'aver politicamente facilitata la fine della solidarietà nazionale che sarebbe ugualmente terminata. La domanda che invece mi pongo è: quale ulteriore sviluppo avrebbero avuto i rapporti tra i partiti sul piano dello sviluppo democratico del nostro paese se Moro avesse ancora potuto guidare la Democrazia Cristiana?
Lusetti: In un'intervista Valerio Morucci ha affermato che l'obiettivo delle Brigate Rosse era quello di colpire un esponente della DC che rappresentasse in modo significato i trentacinque anni di «potere» deomocristiano. La scelta fu, secondo Morucci, tra Fanfani Andreotti e Moro e la scelta cadde su Moro perché in quel momento era il più debole dal punto di vista delle strutture difensive. Io credo che la cosa non sia così semplice: in quel momento della storia politica del paese non poteva essere assente nella direzione strategica delle Brigate Rosse la valutazione che colpendo Moro si colpiva il progetto di solidarietà nazionale che proprio Moro aveva in mente.
Le tappe successive della storia del paese hanno seguito come ha già detto Zaccagnini, una maturazione politica non certamente determinata dalle BR. La storia segue il suo corso. L'obiettivo principale dei brigatisti era quello di scardinare le istituzioni e soltanto all'interno di questo disegno, secondo cui la DC andava colpita proprio perhcé rappresentava le i tituzioni, si inserì forse la scelta di rallentare il processo di avvicinamento tra d mocratici cristiani e comunisti. Altre, ripeto sono state comunque le ragioni che hanno determinato il successivo sviluppo dei rapporti tra i partiti.
L'uscita dalla cosiddeua «emergenza» sembra particolarmente lenta e difficile soprattutto dal punto di vista della revisione delle norme legislative. La carcerazione preventiva, soprattutto, evidenzia oggi enormi limiti e contraddizioni (dal caso Naria al rischio, in non pochi casi di vanificare il lavoro di anni in conseguenenza della riduzione dei termini). Può uno Stato democratico scaricare sugli imputati, non colpevoli fino alla condanna definitiva secondo la Costituzione, le conseguenze delle proprie lentezze e dei propri ritardi?
Zaccagnini: La risposta evidentemente non può che essere «no», lo Stato non può far questo. Di fatto però quando queste lentezze ed insufficienze esistono non è pensabile neppure di poter rimediare in poche settimane. È una situazione alla quale mi pare il Ministro Martinazzoli abbia acutamente posto attenzione, cercando anche di approntare alcuni strumenti, uno dei quali, proprio sulla carcerazione preventiva, ha avuto una grandissima approvazione parlamentare, anche se poi ha creato un certo allarme sociale per le conseguenze della sua attuazione. È un terreno sul quale è possibile fare ulteriori passi avanti, ma con molta prudenza, tenendo cioè presente quali sono le condizioni in cui opera la giustizia, non per insufficienza di uomini ma per carenza di mezzi e di strutture.
Va riconosciuto il limite dell'azione politica. Ricordo che De Gasperi, creando una qualche reazione in noi che eravamo allora giovani diceva che la democrazia è una lunga pazienza. È una definizione molto giusta che però non può evidentemente condurre a concludere che quindi non c'è niente da fare se non aspettare: occorre invece un impegno per cambiare, cambiare naturalmente tenendo presente quali sono i limiti che la realtà sempre pone ad ogni nostra tensione politica, morale od ideale.
Martinazzoli: No. E proprio per questo i più recenti provvedimenti legislativi, come la riduzione dei termini di custodia cautelare, le nuove norme per l'arresto in flagranza e il nuovo rito direttissimo, sono da considerare doverosi.
Non è possibile, in effetti, addebitare ai cittadini il prezzo delle inefficienze istituzionali. Ma proprio per questo la volontà riformatrice, da sola, non è sufficiente. È urgente un impegno non meno attento sulle questioni strutturali, organizzative e finanziarie.
Le cose, insomma, sono più lunghe e consistenti di come si possono sintetizzare nella metafora della «uscita dalla emergenza». Il passato, infatti, è incancellabile e ciò che occorre capire è «come» ci è possibile non incontrarlo di nuovo. Il compito non è semplice, perché in realtà si tratta, più in generale, di recuperare autorevolezza alle istituzioni e di tessere un rapporto più intenso tra la politica e la vita. Vorrei, peraltro, essere anche più franco. Su un terreno come quello della istituzione giudiziaria si riscontrano tutte le difficoltà proprie ad ambiti in cui le scelte tecniche banno grande rilievo e, insieme, i margini di opinabilità delle opzioni sono assai frastagliati. Allora, occorre mettersi in gioco, piuttosto che alimentare troppo fiorenti scuole critiche. Anche dire che non deve, lo Stato, porre a carico dei cittadini le sue inefficienze rischia di diventare un sofisma se sottintende una distanza, quasi la pretesa di una neutralità.
Lo Stato del quale parliamo è questo, di questa storia, di questo tempo. Siamo noi. E ciascuno di noi ha diritto di parlare di queste cose senza rimorsi se, per quanto lo riguarda, è in grado di presentare conti in pareggio tra quanto chiede e quanto è disposto a dare.
Lusetti: Come ba detto Zaccagnini: la risposta non può che essere no. Colmare lacune di tanti hanno gii non è facile con provvedimenti legislativi di questo tipo. Le carenze negli organici della magistratura, le disfunzioni nel funzionamento della giustizia creano questi casi umani, che diventano inevitabilmente politici, come quello di Giuliano Naria.
La riduzione dei termini di carcerazione preventiva era ormai un fatto obbligato e non più rinviabile. Siamo anzi ancora lontani da una situazione ottimale: l'imputato ba diritto di essere giudicato in forma definitiva in tempi brevi, direi umani, senza essere costretto a pagare, sulla propria pelle, lentezze e carenze che non dipendono da lui. Per questo il legislatore deve accompagnare ai provvedimenti di progressiva riduzione dei tempi di carcere preventivo un'azione urgente e massiccia di potenziamento di organici e strutture della giustizia, in grado di accellerare i processi e di evitare così il rischio, reale, di vanificare, con la liberazione di parte dei detenuti in attesa di giudizio, il prezioso e duro lavoro di tanti magistrati.
Albertazzi: Lo stato liberale, in casi di arresti politici, ba sì usato un'istituzione vecchia come la carcerazione preventiva però non per un periodo così lungo come quello utilizzato in questi anni. Le ragioni di tutto ciò sono evidenti, tuttavia va detto che uno Stato democratico deve rendere giustizia nel modo più rapido possibile; di questo ce ne stiamo rendendo conto tutti: non possiamo mancare perciò, se vogliamo uscire dall'emergenza, di dare valore, corposità, spessore e dignità alla magistratura.